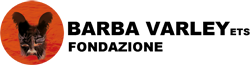Eugenio Barba: rompere le regole – ricerca o rivolta
Non ho mai ragionato in categorie di “ricerca”. Ammiro chi afferma di svolgerla, ne apprezzo i loro vari sviluppi e risultati e sono consapevole di quanto sia importante per l’ecologia del nostro mestiere. Ma la “ricerca” non ha mai motivato le mie decisioni.
Può darsi che uno spettatore o uno studioso consideri i miei sforzi professionali come “ricerca”. Ho sempre pensato, e lo penso tutt’ora, che il teatro sia lo spettacolo, il corpo a corpo degli attori con lo spettatore. Il teatro è lo spettatore. In questo consiste la nostra identità e specificità professionale dal punto di vista storico e tecnico.
La dimensione della “ricerca” – rottura di abitudini, parametri e criteri consueti – è per me organicamente inerente al processo di sviluppo degli attori durante le prove di uno spettacolo. Ogni regista segue cammini diversi.
Il mio procede aggrovigliando la diversità delle improvvisazioni dei singoli attori e intrecciandole in scene drammaturgicamente zigzaganti e ambigue. Considero mio compito stimolare gli attori verso reazioni che intensifichino fisicamente e vocalmente i particolari della storia in modo da attaccare il sistema nervoso e l’immaginazione dello spettatore.
I risultati sorprendono anche noi che abbiamo messo in moto ed elaborato questo processo. La necessità di costruire situazioni che non si lasciano dominare razionalmente è dovuta alla mia incapacità di realizzare uno spettacolo in poche settimane.
Era una forma di insicurezza; dopo più di sessant’anni di esperienza e diventata “attesa attiva”, un processo che fa apparire l’inatteso. Per questo prolungo il periodo delle prove per mesi e mesi, a volte anni.
Gli esempi che oggi sono spesso citati come “ricerca” – gli Studi di Stanislavskij, Vakhtangov o Mejerchol’d – erano scuole teatrali, le prime a sorgere nel Novecento per preparare gli attori alle sfide di innovativi drammaturghi come Ibsen, Strindberg, Cechov e poi dei simbolisti Maeterlinck, Hamsun e Andreyev.
Queste scuole erano spesso all’interno di un teatro, altre volte erano al di fuori e preparavano attori che si sarebbero poi dovuti inserire nel “Mercato” degli spettacoli. L’Actors’ Studio a New York o la casa-scuola di Etienne Decroux a Parigi sono esempi ben conosciuti. Vi era però un’abissale differenza tra queste due situazioni: la prima preparava per il “Mercato”, la seconda rifiutava di prenderlo in considerazione e Decroux mandava via i suoi studenti che cercavano di entrarvi durante i loro studi.
Il “Mercato” non è un’entità negativa. È il contesto della realtà tradizionale, geografica, culturale, sociale, politica e tecnologica. È l’arena della nostra sopravvivenza economica.
Il Mercato è il luogo dell’incontro, delle trattative, degli accordi, dei vincoli, dei confronti e delle dissidenze che determinano il valore della relazione essenziale alla quale Jerzy Grotowski riduceva il teatro: l’Attore e lo Spettatore. Una simile relazione può avvenire solo grazie alle iniziative e alle soluzioni con cui ognuno di noi affronta il Mercato per proteggere la propria autonomia.
Se vogliamo creare uno spettacolo, dobbiamo prendere in considerazione politici e mecenati, leggi teatrali e mode, spazi disponibili e modelli architetturali, modi di informazione, sistemi di produzione/distribuzione e aspirazioni individuali artistiche, didattiche, politiche, terapeutiche e spirituali. La costruzione della relazione attore-spettatore si dibatte tra pragmatismo e idealità, rifiuto e consenso, resistenza e acquiescenza.
Il Mercato è lo spirito del tempo, lo specifico ambito storico in cui ci dibattiamo, ma è anche la massa fluida di un oceano in cui, come pesci, noi artigiani della scena nuotiamo. Possiamo seguire le correnti, andarci contro, cercare di evitarle appiattendoci nel fondo o tentare di diventare pesci volanti per sfuggire ai flussi e alle pressioni di questo mondo liquido che imprigiona. Ognuno di noi sceglie come confrontarsi con il Mercato.
Il Mercato è una dimensione fondamentale della professione dello spettacolo dal vivo insieme al suo aspetto complementare: l’idealità, il valore che ognuno di noi attribuisce al nostro mestiere, il senso intimo che ci spinge a non desistere.
È in questa polarità che il teatro – in quanto incontro con lo spettatore – diventa un concreto sistema di produzione e di creatività specifica con una rete di relazioni che a volte creano un ambiente parallelo, outsider eppure fortemente connesso alla sua epoca. Un gruppo di teatro.
Lo storico italiano Nando Taviani aveva definito “enclave” questi ambienti paralleli. A me interessa mantenere la diversità e l’incomunicabilità delle singole persone che costituiscono la mia enclave, il mio gruppo teatrale, la mia isola galleggiante. Mi appassiona intrecciare questa differenza con la differenza di altre enclave teatrali che cercano di opporsi alla pressione dell’acqua sovrastante.
La “ricerca” non è una forza che mi spinge, a me interessa la politica con altri mezzi, quelli del teatro, una “politicalità” che offre la possibilità di creare un ambiente con un fulcro diverso di relazioni.
La politica è nostalgia di cambiamento, rifiuto dei limiti di quello che si considera possibile, bisogno di realizzare situazioni impossibili. In questo consiste il mio mestiere – la mia rivolta e solitudine – con il lavoro quotidiano all’Odin Teatret.
Non è “ricerca”, è politica. Per questo parlo di una “tradizione dell’impossibile” che attraversa la professione della danza e del teatro e rivela la capacità di alcune personalità di realizzare quello che i loro contemporanei consideravano impossibile.
Qui debbo ricordare, Isadora Duncan e Stanislavskij, Mejerchol’d e Vakhtangov, Bertolt Brecht e Helene Weigel, Judith Malina e Julian Beck con il loro Living Theatre, Joan Littlewood e il Theatre Workshop, Ariane Mnouchkine e il Théâtre du Soleil, La Candelaria di Santiago Garcia e Patricia Ariza, e gli innumerevoli teatri di gruppo dell’intero pianeta – quelli che chiamo il Terzo Teatro – che hanno inventato sistemi di produzione, tecniche e modalità creative per arrivare a spettatori nelle zone ferite e trascurate della nostra società.
Erano spinti da un desiderio di ricerca estetica e artistica o da uno spirito di rivolta verso le condizioni stagnanti, compiaciute e ingiuste del nostro mestiere e della società del proprio tempo?
Un passo alla volta verso una coabitazione tecnica
Per quanto lontano desideriamo andare, per quanto in alto sentiamo il bisogno di continuare a scalare, dobbiamo sempre cominciare con un piccolo passo.
L’International School of Theatre Anthropology (ISTA) non nacque come una necessità di ricerca originale. Nel 1980 Hans Jürgen Nagel, direttore del Kulturamt di Bonn in Germania, mi propose di organizzare un incontro/festival di teatri di gruppo. Io gli feci una controproposta: il progetto abbastanza indefinibile di una “non-scuola”.
La immaginavo come una “convivenza tecnica” basata sullo scambio di pratiche tra attori e danzatori di diverse culture e tradizioni, e riflessioni del presente e del passato di studiosi, coreografi, antropologi, registi di teatro di gruppo e riconosciuti maestri di tradizioni asiatiche. Era possibile definire i fattori che determinavano l’efficacia delle diverse tecniche di attori e danzatori del pianeta?
Misi su l’ISTA, questa “scuola non-scuola”, con studiosi di università ai quali ero legato da profonda amicizia e continui scambi. A loro si aggiunsero attori asiatici che avevo invitato all’Odin Teatret e con i quali avevo spesso collaborato. Ma quale doveva essere il primo passo? Non avevo dubbi: il primo giorno del loro apprendistato.
Da qui l’irragionevole e salda ossessione da parte mia di esigere da questi artisti e studiosi di eccezione, di ricostruire in dettaglio cosa fosse avvenuto durante il primo incontro con chi aveva trasmesso loro i primi rudimenti del mestiere.
Per ogni artista e artigiano, in un processo creativo, l’elemento determinante non è razionale. È spontaneo, incontrollabile e intuitivo. È con le ferite di una biografia che una vocazione per il teatro diventa arte e la trascende.
La vocazione è una fuga. Nasce dal disaccordo con la famiglia, dal dissidio con il mondo, da un’insofferenza o insurrezione permanente, da un’incapacità di adeguarsi e di sentirsi preso in considerazione. La vocazione può essere realizzata gettandosi nella mischia della politica, della militanza, del dissenso e dello scontro.
Oppure, in scala minore, più modesta ma non meno efficace, prende forma in una chiesa, una classe di una scuola, un’associazione culturale o un gruppo di teatro.
Il teatro, ovvero la tecnica dell’attore, non è solo un mezzo, è anche un fine, e per “essere” deve “esistere”. Esser un buon teatrante non significa essere un buon militante, ma riuscire a manipolare e intensificare la “vita” della finzione scenica per manifestarne la realtà interiore. La “vita” scenica è anteriore alla storia, all’aneddoto, all’esplicito. La danza ne è la prova.
Questa “vita” materiale e concreta segue una forza: l’intuizione della bellezza che commuove come vulnerabilità, trascendenza, rifiuto, impulso a resistere, nostalgia e ossessione.
La finzione scenica non solo rivela la realtà ma il anche il suo inverso: quello che non si vede, quello che non si può percepire normalmente. Così come in letteratura i personaggi sono fatti di parole e del modo come queste sono intrecciate, così in teatro i personaggi sono fatti di tensioni, di cambiamenti e salti di energia.
Un sorriso è la conseguenza di duecento cinquanta tensioni nel corpo. Le tensioni sono tramezzi, i muri divisori su cui si costruisce la struttura (drammaturgia) narrativa ed evocativa. Questi muri divisori possono essere costruiti senza prendere in considerazione le regole che sembrano dominare il nostro mestiere e il Mercato.
Potremmo dire che l’alchimia del teatro, con la sua molteplicità di approcci, consiste nel trasformare le sventure in bellezza dolorosa, mettere in crisi le certezze del senso comune, difendere una libertà personale che sentiamo come un dovere morale e una necessità fisica.
Tutto questo può avvenire solo attraverso un’artificialità fisica e vocale che diventa paradossalmente più intensa della vita reale.
Far scendere il cielo dal cielo e piantarlo nella terra, nel corpo-in-vita dell’attore. L’antropologia teatrale aiuta a renderlo possibile.