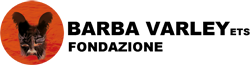L’altra faccia del teatro
Eugenio Barba e Julia Varley dialogano con Miguel Rubio**
Julia Varley: Il titolo di questo incontro, “L’altro lato del teatro”, nasce dal nostro interesse ad ascoltare non tanto la tecnica teatrale, quanto le motivazioni e le storie personali, con i loro dettagli e aneddoti. La prima domanda che vorrei porre riguarda il primo incontro tra Miguel ed Eugenio. Fu nel 1978, durante un incontro di gruppi teatrali organizzato da Cuatrotablas ad Ayacucho, una piccola città delle Ande. Cosa accadde durante questo primo incontro?
Miguel Rubio:
Ho sentimenti contrastanti riguardo al mio incontro con l’Odin; è stato fascino e rifiuto allo stesso tempo. Ricordo vividamente i bambini che guardavano Tage Larsen sugli enormi trampoli, e uno di loro che diceva: “Mamma! Sono passati dei gringos!”. La mia diffidenza mi ha impedito di godermela appieno. La mia mente non riusciva ad accettarlo.
All’epoca scrissi un articolo molto duro per una rivista di sinistra. Il titolo recitava “Yuyachkani prende la parola”; un articolo che rifiutava gli invasori, i nuovi colonizzatori e i predicatori. Ricordo che anni dopo andai a Holstebro, Eugenio tirò fuori la rivista e mi disse: “Ti ricordi questo articolo?”. Oggi abbiamo un rapporto di rispetto e profonda amicizia che ci rende diversi ma con legami molto forti.
Da allora, la nostra famiglia si è diffusa in Danimarca, nella lontana Holstebro. Oggi, ci è così familiare che proveniamo da un’altra tradizione, quella dei vecchi maestri latinoamericani: Santiago García, Enrique Buenaventura, Atahualpa del Cioppo, María Escudero, Augusto Boal, Osvaldo Dragún, Vicente Revuelta, tra gli altri, maestri che ci hanno chiamato a inventare il teatro.
Eugenio Barba:
Quando arrivammo in Perù nel 1978, l’Odin Teatret era abituato ad essere attaccato dai gruppi politici europei. Era il decennio di una nuova cultura teatrale. Molti gruppi erano ideologicamente di sinistra, almeno negli slogan, ma in termini di impatto teatrale – cioè, impatto sensoriale – erano molto deboli. Quindi considerai naturale la reazione dello Yuyachkani. Certo, quando la rabbia o l’indignazione rimangono solo parole, è come un chirurgo che, pieno di rabbia e indignazione per l’ingiustizia della medicina nella società, continua con il suo slogan invece di diventare un chirurgo migliore e aiutare il paziente.
Era molto difficile far capire a quei gruppi politici che la vera battaglia consisteva anche nell’affinare gli strumenti del mestiere, non nel parlare nella speranza di convincere. Non si convince il pubblico se lo spettacolo non rivela momenti di dubbio e autoironia che hanno a che fare con la bellezza, la meraviglia e una realtà diversa.
Julia Varley: Ora vorrei passare alla potenza dell’immaginario che create entrambi quando lavorate ai vostri spettacoli. Da dove nasce questa potenza dell’immaginario, questa teatralità, questa spettacolarità?
Eugenio Barba: Ho assorbito alcuni elementi dalla cultura della mia famiglia, caratterizzata da un certo status sociale, con un particolare modo di pensare, di comportarsi e, soprattutto, un particolare approccio alla ritualizzazione della vita quotidiana. Una delle immagini più forti che ho è quella di mia nonna, con cui condividevo una stanza. Mia nonna era anziana, aveva i capelli bianchi e ogni mattina si alzava alle cinque, si metteva davanti allo specchio e passava moltissimo tempo a pettinare quei lunghissimi capelli.
Nel mio letto, sveglio, osservavo i suoi gesti, i suoi movimenti, le sue posture, il cui ritmo quasi rituale era così carico di energia e trasparenza. Quando vedo il lavoro dei miei attori, mi chiedo se non stia cercando di trovare in ciò che fanno – anche se è molto diverso da ciò che faceva mia nonna – quello stesso senso di arcaicità.
Ho sempre desiderato che il teatro fosse il luogo in cui l’attore potesse trasmettere allo spettatore quell’esperienza di non capire qualcosa e allo stesso tempo di avere la sensazione che l’attore gli stia dicendo qualcosa di molto importante.
Miguel Rubio: Da bambino, vivevo in un quartiere operaio vicino al centro di Lima. Dall’altra parte della strada rispetto a casa nostra c’era la tenuta Heeren, dove viveva la famiglia dell’ex presidente Pardo. Per i bambini del quartiere, era un luogo di fantasia. Ci intrufolavamo per spiare la vita della famiglia, soprattutto alle feste che organizzavano nei giardini incolti. Di notte, il maggiordomo portava i segugi a spasso per il quartiere. Ce n’erano una cinquantina, che rovistavano tra i rifiuti. Osservare tutti questi contrasti intorno a me stimolava la mia immaginazione.
A pochi isolati di distanza, c’era una caserma militare da cui partiva la scorta a cavallo del presidente. C’erano circa sessanta uomini a cavallo, impeccabilmente vestiti, alcuni con strumenti a fiato e a percussione. Una carrozza in stile coloniale trainata da cavalli chiudeva la fila. Erano diretti al palazzo presidenziale per accompagnare il presidente a una cerimonia ufficiale. Tutto questo succedeva proprio davanti alla mia porta. E a cinquanta metri di distanza, la chiesa della Vergine del Carmen, dove un tempo si tenevano feste, processioni e fuochi d’artificio, che completavano il quadro di una sontuosa teatralità in cui ho vissuto la mia infanzia.
Queste immagini visivamente suggestive, con cui avevo convissuto per così tanto tempo, le ho riscoperte in seguito durante i viaggi con il gruppo alle feste tradizionali andine. Questa teatralità delle culture ci ha dato lo slancio per mettere in discussione la nozione di teatro basato sul testo, ed è diventata un principio fondamentale del nostro teatro: il teatro non è letteratura, il teatro non è un genere letterario. Questo si rafforza quando osserviamo altre forme di scrittura nella nostra storia. Le nostre culture native non avevano una scrittura letteraria; la scrittura era imposta con la forza. Pertanto, rivalutare queste altre forme di scrittura è stato fondamentale per riconoscere ciò che è scritto sul corpo, sulle ceramiche, sui tessuti, sui murales e così via.
Questo è anche uno dei motivi per cui, a Yuyachkani, è stato naturale lavorare a partire dal corpo e dagli oggetti. Utilizziamo molti oggetti, non necessariamente costruiti, ma oggetti trovati a cui viene dato un nuovo significato sul palco. Il nostro ultimo lavoro, Discurso de Promoción (Discorso di Laurea), riunisce tutti gli oggetti utilizzati alla fine, dando l’impressione di un’immensa discarica. Si tratta di oggetti per lo più abbandonati nel deposito di Yuyachkani.
Julia Varley: Sia Miguel che Eugenio hanno lavorato con le stesse persone, con un gruppo che esiste da più di 50 anni, con le stesse persone.
Conosciamo alcuni gruppi che sono solo una coppia, ma Yuyachkani e l’Odin Teatret sono rarissimi esempi di persone che sono rimaste insieme per decenni. Come registi, cosa vi spinge a continuare, o forse a non volerlo più, non so, con le stesse persone?
Eugenio Barba: Il fatto di lavorare con gli stessi attori va contro la natura del teatro. Il DNA del teatro è costituito da una doppia contingenza: da un lato, deve poter generare reddito per sostenere chi lo fa, quindi l’aspetto economico è determinante e questo condiziona il sistema produttivo, i risultati, le tecniche degli attori, tutta la loro cultura materiale. L’altra caratteristica del DNA della nostra professione è la natura effimera delle relazioni. Tutte le compagnie teatrali, gli ensemble, i gruppi, tutti si sciolgono dopo un certo periodo. C’è una durata contrattuale che rispettano, e poi se ne vanno, per mancanza di lavoro o per cercare qualcosa di meglio.
Questa era la grande utopia di Stanislavskij: un teatro d’arte, un regista, attori e altri collaboratori con un’affinità estetica e una visione artistica condivise. Parlava di etica e considerava l’attore un artista, un creatore dotato di dignità e originalità. Ho fondato l’Odin Teatret come un gruppo di dilettanti. Alcuni attori se ne sono andati, ma è sempre rimasto un nucleo centrale. Questo mi ha fatto pensare: “Voglio lavorare con questi attori fino alla morte”. Ma a teatro, le persone rimangono finché ci sono interessi comuni, uno stimolo – che può essere artistico, economico o politico. A volte si innamorano e il partner non può unirsi al gruppo, quindi vanno dove c’è l’amore. Altre volte, il lavoro in sé non è stimolante e cercano qualcosa di più interessante.
Questo mi ha costretto a trovare una dinamica completamente diversa all’interno del mio gruppo. Da un lato, cerco di creare situazioni stimolanti per lavorare insieme a un progetto comune che ci unisca. D’altro canto, ci sono periodi in cui ogni membro dell’Odin Teatret può perseguire la propria individualità, le proprie idiosincrasie e i propri desideri. Quella dinamica di gruppo di introversione ed estroversione, centrifuga e centripeta nell’Odin Teatret ha permesso questa innaturale durata dei nostri rapporti di lavoro.
Miguel Rubio:
Penso che la cosa più sana sia che le nuove generazioni esercitino il loro diritto a creare i propri progetti, proprio come abbiamo fatto noi di fronte ai nostri insegnanti. Yuyachkani può essere un’ispirazione o un punto di riferimento, ma non un vincolo alla creazione. Credo di avere le idee chiare su questo, e non mi spaventa, che se Yuyachkani dovesse concludersi con la scomparsa fisica dei suoi membri, spero che finisca bene, che finisca con dignità. Non vorrei che nessuno cercasse di replicare l’esperienza in nome di ciò che abbiamo fatto. Non ho avuto tempo di pensare in questi anni se voglio o meno lavorare con i miei colleghi. Non ho avuto tempo perché è stato così, così vertiginoso, così intenso, così potente che all’improvviso mi rendo conto che tra due mesi festeggeremo cinquant’anni di lavoro, e sono stupito di come il tempo sia volato e di come sia stato questo processo.
Abbiamo vissuto delle crisi e vi abbiamo risposto con il nostro lavoro. È stata una sfida costante, è stata il nutrimento e il fondamento del nostro sviluppo. Viviamo anche in un Paese in crisi permanente.
Penso che il teatro viva, cresca e si sviluppi attraverso il suo rapporto con il mondo esterno, più che attraverso ciò che accade nello spazio chiuso del teatro. È una sensazione di sfida costante che alimenta il desiderio di imparare.
Julia Varley: Il teatro è politica attraverso altri mezzi. Cosa significa questo in questi tempi di incertezza? Miguel, so che hai lavorato a lungo per il Museo della Memoria, che esiste sia ad Ayacucho che a Lima. L’Odin Teatret ha avuto molte esperienze di baratto, allontanandosi dal teatro come rappresentazione e cercando di rendere il teatro un’esperienza diretta per il pubblico. Quindi la domanda è: in questi tempi, se il teatro è politica attraverso altri mezzi, quali percorsi intravedete oggi?
Eugenio Barba: È fondamentale definire le parole che usiamo, soprattutto quando immaginiamo che tutti le capiscano. Cosa significa per me la politica? Se provo a spiegarlo, la politica è un desiderio di cambiamento. Non mi piace ciò che esiste! Ecco perché ero comunista, perché pensavo che la politica potesse cambiare. Dopo il mio periodo in Polonia, un paese comunista con censura, polizia segreta, mancanza di libertà di espressione e divieti di viaggio, tutto questo mi ha vaccinato contro la politica e le ideologie. Ma il desiderio di cambiamento è rimasto. Quindi, come si fa politica senza passare attraverso il discorso politico, per i media che normalmente caratterizzano la politica, che sappiamo essere l’arte del compromesso? Questo è il teatro per me: comunicazione emotiva: danza e canto che esprimono ciò che tocca la parte più profonda dell’essere umano.
Da giovane, pensavo che una rivoluzione potesse cambiare la società. Oggi, penso di essere semplicemente un umile insegnante in una scuola con dieci studenti, e il mio compito, nonostante quello che sta succedendo nel mondo, è quello di dare a quei dieci studenti il meglio che posso. Dare il meglio significa che ognuno deve imparare a difendere la propria differenza. Perché ciò che tu chiami identità, per me, è differenza: la conquista della propria differenza! La gente mi dice: “Alla tua età, puoi stare tranquillo, perché continui, perché questa testardaggine?”. È testardaggine perché non voglio che quella nostalgia muoia. Se muore, muore con essa l’intero significato di ciò che ho fatto per tutta la vita. Quindi continuo a dare segnali a un gruppo molto piccolo di persone; alcune non so nemmeno dove siano o come stiano, forse hanno letto uno dei miei libri, non mi conoscono personalmente. Ma so che questo piccolo gruppo esiste, e per loro sono come l’insegnante di una scuola in un piccolo villaggio in India. A quegli studenti seduti per terra, cerco di insegnare il mistero della scrittura, di quei simboli sulla carta, in modo che possano scrivere le proprie poesie. Ho già scritto le mie poesie, insieme a un gruppo di attori e attrici, per cinquantasei anni.
Miguel Rubio: Il primo spettacolo che abbiamo messo in scena cinquant’anni fa si intitolava Pugno di Rame, e la sua ispirazione è nata da ciò che vedevamo nelle strade di Lima: marce di donne, madri, mogli e bambini che denunciavano il massacro di venticinque minatori/operai nel centro della città.
Stavamo pensando a quale spettacolo mettere in scena, e nelle strade c’era questa impressionante mobilitazione di donne con i loro figli e i loro mariti incarcerati. Lì stava la sfida concreta. Perché non creare uno spettacolo che fosse al servizio di quella lotta? Così abbiamo deciso di andare alle loro assemblee e dire loro: “Creeremo uno spettacolo per raccontare la vostra storia”.
Non sapevamo nemmeno noi come farlo. Siamo andati in prigione a trovare i minatori incarcerati e a intervistarli. Le donne del gruppo sono andate alle cucine comunitarie per preparare il cibo, noi siamo andate a distribuire volantini e a partecipare a tutte le assemblee, e quando abbiamo finito, dopo otto mesi di lavoro sullo spettacolo, gli operai sono stati rilasciati dal carcere e sono tornati alle loro case. Dovevamo recarci nei campi minerari per presentare il lavoro.
Quando qualcosa è vero, ha una fonte di bellezza. Non cerco una bellezza separata dalla verità. Quindi credo che questo principio operativo sia stato importante nella scelta di ciò che facciamo. Non avere una posizione politica nel nostro Paese è impossibile, perché ci viene negata persino la cittadinanza. In un Paese come il nostro, i diritti più basilari dei cittadini vengono negati. Ecco perché è naturale che pensiamo sempre in termini politici.
Ci sono stati anni in cui Yuyachkani non ha messo in scena uno spettacolo teatrale in sé; facevamo azione. Quell’azione è stata importante; ha nutrito la nostra visione del teatro, perché passare dal fare teatro all’ingresso di una sala sindacale alle sei del mattino al fare teatro su un autobus mentre i minatori, gli operai, camminavano, intrufolandosi in un posto da minatori, fare teatro in un’assemblea con millecinquecento minatori, tutti con il casco e una luce – è stato bellissimo, impressionante… ancora più impressionante è stato quello che è successo dopo lo spettacolo, che gli operai sono venuti a esprimere la loro solidarietà, a parlare dello spettacolo, a discuterne.
E restituire quell’apprendimento è stato molto, molto importante, e credo che sia questo ad aver alimentato questa vocazione politica che non abbiamo mai nascosto. Molte persone che recensiscono i nostri lavori direbbero: queste persone non hanno fatto teatro, perché dove sono le opere di chi fa… opere classiche? Ma noi abbiamo fatto teatro mettendo i nostri corpi dove era necessario metterli, e lo abbiamo fatto rendendo testimonianza del nostro tempo. Siamo attori testimoni del nostro tempo, e in questo, abbiamo forse creato un’unica opera con molti atti. Credo che abbiamo continuato il percorso iniziato con la nostra prima opera.
*L’intervista è un estratto tratto dalla “Conversazione sui Senza nome, 2021”
**Regista peruviano, ricercatore teatrale e membro fondatore del Grupo Cultural Yuyachkani.